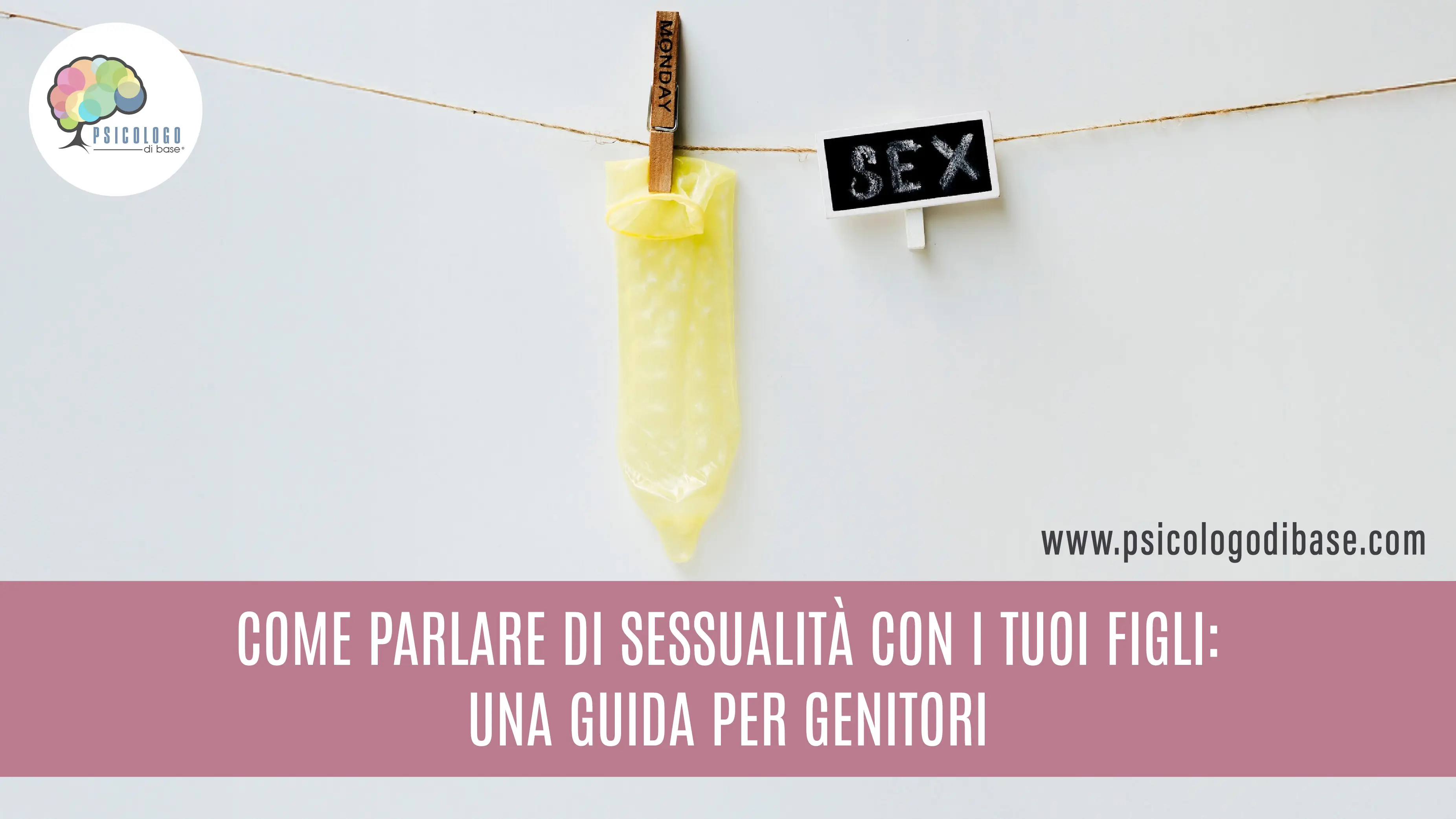Figli e alta conflittualità genitoriale
- Psicologia e Territorio
- Visite: 1007
All’interno delle famiglie è possibile che possano crearsi situazioni di conflittualità e che a risentirne maggiormente siano i figli, specialmente se minori. I litigi possono diventare sempre più frequenti e si possono verificare episodi di violenze e maltrattamenti. Prima che si manifestino condizioni estreme, è auspicabile chiedere aiuto.
Come comprendere se ci si trova di fronte ad alta conflittualità?
Il conflitto genitoriale è stato definito come qualsiasi azione, atto o parola che crea ansia, mette il figlio nel mezzo o lo costringe a scegliere tra uno dei due genitori.
Il conflitto può essere sottile ed esprimersi con il tono di voce, il linguaggio del corpo ostile, gli occhi al cielo, l'ignoranza, le battute e il sarcasmo oppure palese, evidenziandosi con minacce di violenza, attacchi verbali e abusi fisici.
Come reagiscono i figli all’alta conflittualità dei genitori?
Le reazioni del figlio, specialmente in adolescenza, possono essere di due tipi:
- di esplosione, con comportamenti antisociali, di violenza, di aggressività;
- di implosione, con problematiche di depressione, isolamento sociale, autolesionismo, problemi psicosomatici, tendenza a compiacere gli altri, genitorializzazione.
Per quanto riguarda i comportamenti antisociali, nel corso dell’adolescenza si formano spesso gruppi di giovani che mettono in atto comportamenti antisociali o trasgressivi, come l’uso di sostanze stupefacenti, la guida spericolata, azioni violente contro l’autorità o contro altri giovani. È importante evidenziare come in adolescenza il legame con il gruppo sia tanto più esclusivo quanto più ci sono problemi in famiglia, in quanto l’adolescente cerca nel gruppo quel tipo di supporto che non riesce a trovare in famiglia.
In che modo lo stile genitoriale influenza il comportamento del figlio?
Per “stile genitoriale” si intende la modalità educativa con cui i genitori svolgono le funzioni genitoriali e, in generale, si rapportano ai propri figli.
In particolare, gli stili genitoriali si distinguono in autorevole, permissivo, autoritario, trascurante/rifiutante. Le dimensioni per le quali questi stili si differenziano tra di loro sono il grado di accettazione/supporto e il grado di controllo/richieste.
- Stile autorevole: è contrassegnato da un’elevata accettazione e da un elevato controllo. Questi genitori hanno ben chiaro il tipo di disciplina da dare ai propri figli, verso cui si dimostrano rispettosi ed emotivamente supportivi. Rappresenta un importante fattore protettivo per comportamenti antisociali e per psicopatologie;
- Stile permissivo: è caratterizzato da un’alta accettazione e da uno scarso controllo. Sono genitori permissivi, disponibili e affettuosi, ma senza un senso di responsabilità circa le decisioni e le condotte dei figli, fornendo loro poche regole o talvolta nessuna;
- Stile autoritario: è contrassegnato da una scarsa accettazione e da un elevato senso di controllo. Si pretende obbedienza, senza mostrare loro alcuna spiegazione. È uno stile freddo, distaccato, punitivo. Può favorire comportamenti antisociali e trasgressivi oppure comportamenti vittimizzazione tipici di coloro che subiscono atti di bullismo;
- Stile trascurante/rifiutante: è contraddistinto da una scarsa accettazione e da uno scarso controllo. Questi genitori mostrano un totale disinteresse rispetto al ruolo educativo, forniscono ai figli pochi strumenti di conoscenza del mondo circostante e non sono emotivamente supportivi per i figli.
Le famiglie che rappresentano un fattore di rischio per la messa in atto di condotte antisociali presentano le seguenti caratteristiche:
- insufficiente controllo educativo, specifico di uno stile trascurante, rifiutante e permissivo; queste famiglie mettono pochi o nessun limite, per cui i figli tendono a porsi in maniera conflittuale;
- famiglie iperprotettive, in cui i genitori trovano difficoltà a percepire la crescente autonomia dei figli;
- episodi ricorrenti di violenza domestica nella coppia genitoriale facilitano una inclinazione all’uso della violenza, che può essere vista dai figli come una forma adeguata di risoluzione dei problemi relazionali.
In generale, per scoraggiare la messa in atto di comportamenti antisociali, assumono un ruolo fondamentale gli interventi di prevenzione condotti all’interno delle scuole e nei confronti delle famiglie che si configurano come potenzialmente a rischio.
Per quanto riguarda i comportamenti di implosione quali depressione, insicurezza e bassa autostima, isolamento sociale, autolesionismo, problemi psicosomatici, tendenza a compiacere gli altri, genitorializzazione, vi è una modalità di sofferenza che viene direzionata verso se stessi.
Dato che la depressione in adolescenza non consiste solamente in umore depresso, tristezza, malinconia occasionali, ma è un disturbo che pervade ogni sfera della vita dell'adolescente: familiare, sociale e scolastica.
È quindi fondamentale che l'individuo, i suoi familiari o gli amici riconoscano e segnalino la problematica affinché venga trattata nel modo più tempestivo ed adeguato possibile.
Se prevale il pensiero pessimistico, gli adolescenti depressi possono convincersi che non sia possibile fare nulla e che sia quindi inutile chiedere aiuto e/o provare a reagire.
La depressione nell'adolescente può manifestarsi con sintomi diversi rispetto a quanto si osserva negli adulti. La lista che segue elenca i sintomi più frequenti: tristezza o disperazione; irritabilità, rabbia, ostilità; frequenti pianti; distacco da amici e parenti; perdita di interessi; insonnia o ipersonnia; diminuzione o aumento dell'appetito; agitazione, difficoltà nel rimanere fermo, oppure al contrario rallentamento nei movimenti e nel pensiero; senso di colpa, inutilità; mancanza di entusiasmo e motivazione; affaticamento, debolezza; difficoltà di concentrazione; pensieri di morte.
Il senso di insicurezza e di bassa autostima può riguardare la sensazione di non sentirsi competenti, meritevoli di rispetto, degni di stima, capaci di essere autonomi e indipendenti.
L’autostima corrisponde al valore che ciascuno di noi attribuisce a se stesso, al grado di accettazione di sé, alla fiducia che si ripone nelle proprie capacità e nel saper affrontare le proprie esperienze di vita e alla rappresentazione che ogni persona ha di sé.
Avere un buon livello di autostima riveste un’importanza centrale in adolescenza, in quanto permette al ragazzo, se pur con difficoltà, dubbi o incertezze, di affrontare le sfide della crescita, di costruirsi un’immagine positiva di sé, di relazionarsi con i coetanei, di fare delle scelte, di sperimentarsi e di muoversi nel mondo con una certa sicurezza e disinvoltura.
L’autostima va nutrita sempre, sin dalla primissima infanzia, in modo tale che quando si arriva all’adolescenza si hanno già delle basi solide, che permettano la costruzione della propria identità e di sviluppare un senso di fiducia verso il mondo esterno e verso le proprie capacità.
Infatti, i ragazzi, anche quando giocano a fare i “grandi” e si mostrano sicuri e indipendenti, in realtà hanno un forte bisogno di essere sostenuti, soprattutto da un punto di vista emotivo, necessitano di essere rassicurati, apprezzati e valorizzati dagli adulti di riferimento, anche se faticano a chiederlo, insieme alla necessità di sentirsi accolti dal gruppo dei coetanei.
I genitori devono essere consapevoli dell’importanza del loro ruolo: le loro parole e i loro comportamenti hanno un peso importante, condizionano profondamente il figlio, soprattutto i loro eventuali giudizi. Per un figlio, sapere che un genitore nutre fiducia in lui, che lo accetta e crede nelle sue potenzialità, lo aiuta ad accrescere la stima di sé e ad essere più sicuro.
Un figlio ha bisogno di una base sicura a cui potersi rivolgere non solo in caso di difficoltà, ma anche per affrontare le nuove esperienze di vita. Questa base è un punto di partenza importante perché ne deriva la fiducia che il figlio ha ed avrà nei confronti di sé e del mondo esterno.
Se è vero che il genitore deve essere base sicura, è vero anche che il figlio deve valutare da sé, non deve essere condizionato dal giudizio che un genitore può rivolgere al coniuge o ex coniuge.
Il genitore che giudica l'altro genitore, mette dubbi e crea paure nel figlio, diventando fonte di insicurezza per il figlio stesso. Il figlio sentirà di non avere scelta, verrà condizionato a pensare che l'altro genitore non lo voglia o sia cattivo e, come una profezia che si autoavvera, il genitore criticato verrà messo sotto torchio, verrà colto in fallo e messo al flagello. Questo fomenterà l'odio del figlio verso il genitore, ma alla lunga anche verso l’altro genitore. Perché non si può costruire una buona relazione con un figlio sulla base di un odio comune. E più avanti quell'odio ricadrà anche sul lato genitore, visto, inconsciamente o meno, come causa della perdita dell'amore dell'altro genitore. Il figlio sentirà di non aver scelta, ma anche di essere stato privato dei suoi diritti.
- Cigoli Vittorio, Galimberti Carlo, Mombelli Marina, “Il legame disperante - Il divorzio come dramma di genitori e figli”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1988
- Dell’Antonio Annamaria, Il bambino conteso. Il disagio infantile nella conflittualità dei genitori separati, Giuffrè, Milano, 1993
- Glasl Friedrich, La gestione sistemica dei conflitti nelle organizzazioni, Utet, Torino, 2021

Autrice
Dott.ssa Giulia Rinaldi
Psicologa e Psicosessuologa
Dottoressa in Psicologia con Laurea Magistrale, iscritta all'albo degli psicologi della Sardegna con il n. 3796