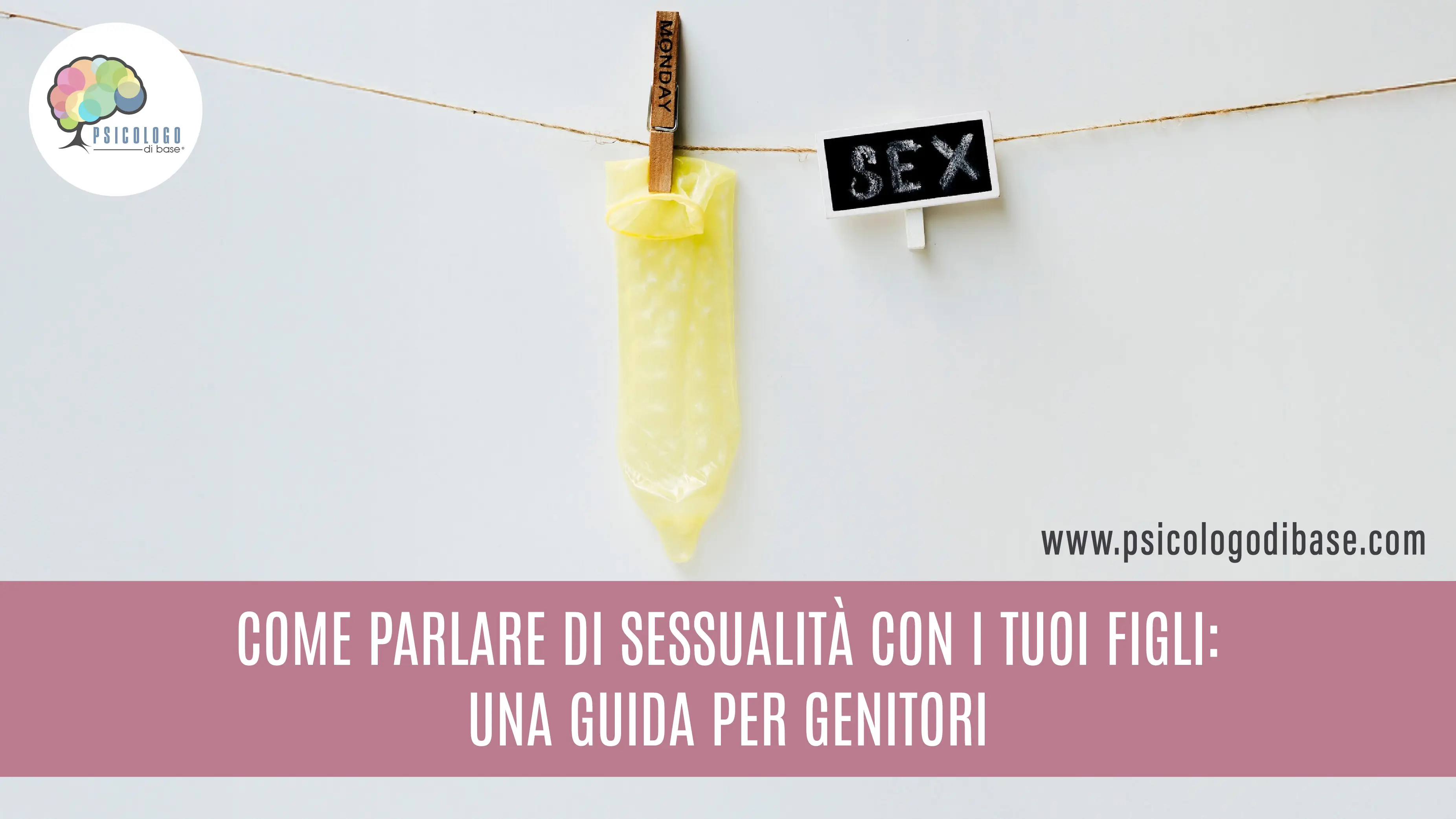L’isolamento: cos’è e quali sono le conseguenze sul nostro cervello
- Psicologia e Territorio
- Visite: 2823
Per isolamento si intende la condizione in cui un individuo vive un periodo prolungato in assenza di relazioni sociali e contatti con gli altri. Si manifesta quando si è fisicamente ed oggettivamente soli, il soggetto non ha alcun contatto con gli altri al punto da vivere muovendosi per la maggior parte del tempo nello stesso ambiente.
L’isolamento è dunque una condizione complessa, che può essere attivamente ricercata dall’individuo, come sintomo o conseguenza di un forte disagio psichico, ma può essere anche subita passivamente, come accade spesso per gli anziani.
Infine, può essere una condizione imposta, come accade per i detenuti e come è accaduto per alcuni di noi durante il periodo della quarantena da covid19.
Una persona isolata si trova ad avere interazioni sociali estremamente ridotte o nulle. L’individuo non vuole (o non può) uscire di casa e si ritrova dunque a muoversi in uno spazio sempre uguale, come ad esempio una stanza, una casa, o, per i detenuti, una cella.
L’isolamento è differente quindi dalla solitudine, che può essere considerata il suo corrispettivo soggettivo, per un approfondimento sulla solitudine
Solitudine e isolamento spesso sono presenti in due condizioni molto diffuse: depressione e Alzheimer.
Quali sono le conseguenze dell’isolamento prolungato sul nostro cervello?
Numerose ricerche hanno dimostrato gli effetti psicologici, fisici e comportamentali dell’isolamento (Manna, 2019; Scharff Smith, 2006).
Dagli studi effettuati emergono tre principali effetti psicopatologici generalizzati dell'isolamento:
- disturbi affettivi, tra cui ansia e a\attacchi di panico;
- pensieri ossessivi, a volte accompagnati da comportamenti compulsivi.
- distorsioni percettive, con deliri e allucinazioni;
Studi su animali dimostrano che un ambiente monotono e poco stimolante porta all’impoverimento delle connessioni già dopo soli quattro mesi (Zigmond, Smeyne, 2019) e che la privazione dei contatti umani, unitamente alla costante produzione di cortisolo in risposta alla situazione stressante, ha gravi conseguenze sul funzionamento di ippocampo e amigdala (Akil, 2019), aree deputate alla memoria e al controllo delle emozioni. La riduzione dell’ippocampo è anche correlata alla depressione e ad una disfunzione della corteccia prefrontale (Pavoncello, 2021). Vi sono altri studi che correlano l’isolamento con un aumento del rischio di sviluppare demenza (Willeumier, 2021). Negli animali, infatti, l'isolamento ha comportato i tipici cambiamenti cerebrali che si verificano nei primi stadi dell’Alzheimer.
Infine, ulteriori evidenze hanno sottolineato altri importanti cambiamenti neurali: una riduzione del fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) e una diminuzione della sostanza bianca.
Come è ovvio, gli effetti dell’isolamento variano da persona a persona, variabili come l’età e le esperienze di vita rendono complessa la ricerca su campioni umani.
Quali sono le conseguenze dell’isolamento prolungato sulle abilità cognitive?
Le modifiche strutturali sopra descritte sono chiaramente correlate anche a modifiche funzionali nelle abilità. Vari studi correlano l’isolamento sociale a prestazioni cognitive complessivamente più scarse, declino cognitivo più rapido, funzionamento esecutivo più povero, accrescimento della sensibilità alle minacce sociali.
Tra le abilità cognitive più compromesse in età avanzata vi è l’abilita di orientamento nello spazio. Inoltre, c’è una correlazione tra l’isolamento sociale e deficit di orientamento e navigazione, per tre motivi principali:
- interruzione della memoria spaziale dovuta all’interruzione delle interazioni sociali e degli stimoli ambientali;
- maggiore dipendenza da segnali interni data dalla condizione di cronica esposizione al cortisolo e dall’impoverimento degli stimoli esterni;
- compromissione dell’elaborazione cognitiva generale;
Il prolungato isolamento, quindi, diviene un importante fattore di rischio per sviluppare un deficit di orientamento. In particolar modo, nei soggetti anziani, è correlato con lo sviluppo di sintomi tipici declino cognitivo e dell’Alzheimer.
Ma come funziona l’orientamento nello spazio?
La navigazione spaziale si riferisce alla capacità di individuare e mantenere un percorso da un luogo all'altro e determinare la propria posizione nello spazio (Wolbers, Weiner, 2014). Le regioni cerebrali coinvolte sono molteplici: ippocampo, corteccia entorinale, complesso retrospinale e corteccia prefrontale.
I numerosi studi in materia evidenziano il fatto che ci sono specifiche cellule con compiti differenziati, questo sistema di cellule integra le informazioni provenienti dai sensi e permette di eseguire complessi compiti di navigazione spaziale in maniera fluida.
Per misurare e abilità spaziali sono stati standardizzati diversi test neuropsicologici e negli ultimi anni si cerca di creare strumenti nuovi, che riescano a misurare questa abilità cognitiva in un contesto ecologicamente sempre più valido. Tali test consistono nella navigazione attraverso ambienti reali e richiedono l'uso della memoria spaziale e dell'orientamento. Un esempio è il Sea Hero Quest, compito di navigazione spaziale disponibile sia in realtà virtuale che per diversi dispositivi mobili che, sotto forma di videogioco in cui il protagonista deve esplorare un territorio, ha permesso di raccogliere un’immensa quantità di dati sul tema che sono stati poi utilizzati per implementare la ricerca sull’Alzheimer (Coughlan, Lowry, Gillings, 2020).
Quali sono le possibili modalità di intervento?
Non è possibile indicare un’unica soluzione adatta a tutte le condizioni. Gli interventi possono essere molto differenti a seconda delle cause che hanno portato all’isolamento e alle conseguenze che lo stesso ha prodotto.
Nel caso in cui l’isolamento sia una condizione attivamente ricercata dall’individuo è necessario un intervento psicoterapeutico che tratti l’ansia sociale e tutte quelle motivazioni per le quali il soggetto cerca attivamente il ritiro ed evita i contatti.
Nel caso di soggetti anziani, spesso con declino cognitivo, è necessario un supporto psicologico unitamente ad interventi di riabilitazione o stimolazione cognitiva che aiutino anche a affrontare la solitudine. In aggiunta, è utile un supporto psicologico anche per i caregiver.
In ultimo, per individui che escono da un periodo di isolamento sociale imposto, è fondamentale avvalersi di un supporto psicologico.
In ogni caso si consiglia di contattare uno psicologo, il quale potrà effettuare una valutazione della situazione individuale tale da indicare il percorso più adeguato. Contattaci ora per una consulenza in studio o online.
Bibliografia
- Manna C. (2019). Gli effes cerebrali dell’isolamento per reclusione.
- Scharff Smith P. (2006). The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief History and Review of the Literature. Crime and Jus9ce, Vol. 34, No. 1 (2006), pp. 441-528 (88 pages)
- J., Smeye R.J. (2019). Use of Animals to Study the Neurobiological Effects of Isola9on: Historical and Current Perspec9vesHistorical and Current Perspec9ves DOI:10.1093/oso/9780190947927.003.0013 In book: Solitary Confinement (pp.221-242)
- Akil H., (2019). The Brain in Isola9on: A Neuroscien9st’s Perspec9ve on Solitary Confinement. Chapter 12. Pp 199-200 doi.org/10.1093/oso/9780190947927.003.0012
- Pavoncello N. (2021). La neurobiologia della solitudine: gli effes dell'isolamento sociale sul nostro cervello. Madadvances
- Willeumier K. (2021). How Social Isola9on and Loneliness Impact Brain Func9on: Imaging studies reveal neural correlates of social isola9on and loneliness Schaeffer C., (2016). “ISOLATION DEVASTATES THE BRAIN”: THE NEUROSCIENCE OF SOLITARY CONFINEMENT. Solitary Watch.
- Wolbers T., Wiener J.M. ( 2014). Challenges for iden9fying the neural mechanisms that support spa9al naviga9on: the impact of spa9al scale. Hum. Neurosci., Sec. Cogni9ve Neuroscience Volume 8 - 2014 //doi.org/10.3389/fnhum.2014.00571
- Coughlan G., Puthusserppaddy V., Lowry E., Gillings R. (2020). Test-retest reliability of spa9al naviga9on in adults at-risk of Alzheimer’s disease. doi.org/10.1371/journal.pone.0239077

Autrice
Dott.ssa Lorenza Napoleoni
Psicologa, Psicoterapeuta in formazione
Iscrizione albo: Umbria nr. 1654